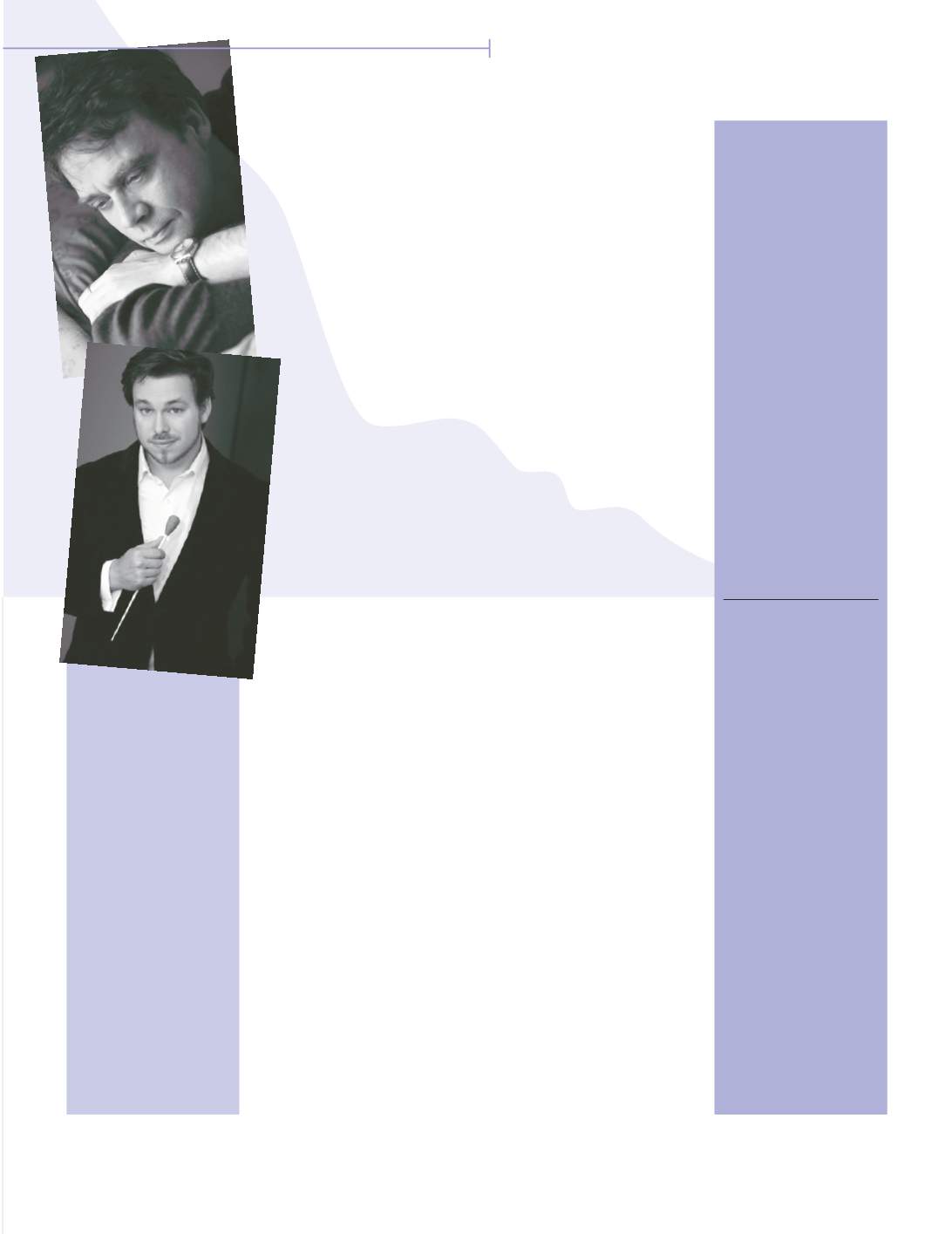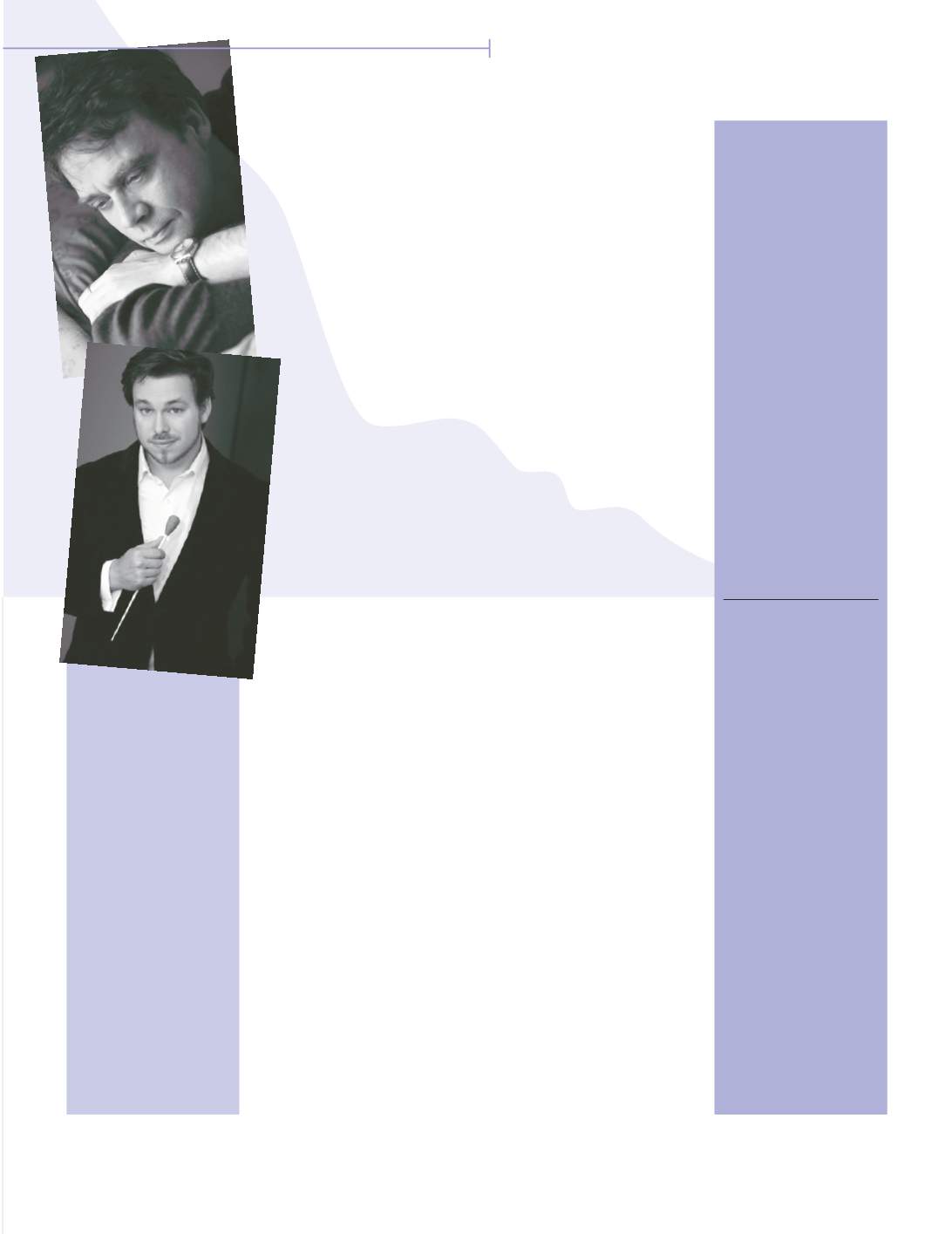
CONCERTI
FUORI SEDE
giovedì 14 aprile
Lugano
Palazzo dei Congressi
Lugano Festival
Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Ryan McAdams
direttore
Paolo Fanale
tenore
Vladimir Baykov
basso
Vadim Repin
violino
Musiche di Prokof’ev,
Rimskij-Korsakov,
¥ajkovskij
pea dell’Ottocento troveremmo almeno due effetti di grande rilievo: la
trasformazione della
Sonata a Kreutzer
di Beethoven in un dramma della
gelosia a opera di Tolstoj e quella della vita intera di Salieri in una tragedia
dell’invidia a opera di Puškin. Dal breve dramma – inizialmente intitolato
L’invidia
– che questi aveva scritto cinque anni dopo la morte di Salieri, nel
1830, Nikolaj Rimskij-Korsakov ha tratto nel 1898
Mozart e Salieri,
opera
in
un atto unico da lui concepita come omaggio implicito ad Alexandr
Dargomyžskij (l’autore che molti anni prima aveva messo in musica un
altro breve dramma mozartiano di Puškin:
Il convitato di pietra
). La par-
titura di Rimskij-Korsakov percorre rapidamente un orizzonte espressivo
che va dal comico al tragico, dalla maschera del divertimento irridente,
che Mozart indossa fino a farne una provocazione continua, all’oscurità
del foro interiore in cui Salieri rielabora l’umiliazione e medita la sua
vendetta. Musicalmente, al di là del gioco delle citazioni e delle
imitazioni, l’elemento che fa da collante alla vicenda è il canto de-
clamato: una soluzione che era stata tipica di Dargomyžskij, che
aveva influenzato profondamente tutto il movimento della nascente
musica nazionale russa e di cui Rimskij-Korsakov dimostra l’estrema
e funzionale duttilità.
La commedia di Peter Shaffer che ha ripreso l’idea di Puškin,
Amadeus
(1978), e il film di Milos Forman basato su di essa (1984) sono solo
epigoni, per quanto di amplissima risonanza, di un processo che ha
eletto la storia a pretesto di una leggenda esemplare, capace cioè di
cogliere e di rappresentare un dato saliente della coscienza moderna.
L’invidia, infatti, non è che lo sfondo che dà corpo all’opposizione fra
la normalità e l’eccezione, fra la disciplina del lavoro e il dono natura-
le del genio, fra il rispetto delle regole date e il gesto di sfida che ne de-
nuncia la fragilità o, al limite, le manda in frantumi. In questa visione
c’è un pregiudizio radicatissimo, un’idea della creatività senza regole,
o fuori dalle regole, che fa corpo con l’immagine moderna dell’arte
come prodotto massimamente autonomo dell’intelligenza umana.
Salieri non andrebbe ricondotto all’invidia ma al rapporto fra quella
che, prendendo a prestito termini introdotti da Thomas S. Kuhn nella
storia della scienza, si potrebbe definire “musica normale” e “musica
rivoluzionaria”. La vicenda di Salieri è l’esempio di una bella normalità,
riconosciuta dal plauso del pubblico e dalla gratitudine degli allievi, il cui
compiuto dispiegamento sarebbe stato turbato non tanto dall’incontro con
Mozart, ma dall’imporsi del nuovo mito romantico che ha avuto in odio la
normalità e ha considerato l’esuberanza del genio, non la disciplina della
scienza, l’espressione più alta dell’ingegno umano.
Un rapporto storicamente più fedele alla “musica normale” di fine
Settecento ci permetterebbe di ascoltare Salieri senza pensare a Mozart.
Visto in questa prospettiva, Salieri può rivelarci anche la sua originalità, la
sua capacità di innovare e di mantenersi all’altezza di un ruolo che richie-
deva costantemente impegno e qualità. Della sua musica, però, si esegue
ancora relativamente poco.
L’Europa riconosciuta
, opera che inaugurò il
Teatro alla Scala di Milano nel 1778 e che fu scelta nel 2004 da Riccardo
Muti per la riapertura del Teatro dopo i lavori di restauro, è uno dei suoi
pochissimi titoli che abbiano avuto l’onore di un allestimento moderno.
Dal 2000, anno in cui ne è stata pubblicata per la prima volta l’edizione
critica (a cura di Elena Biggi Parodi), è invece stato eseguito con significa-
tiva frequenza l’oratorio
La Passione di Gesù Cristo
, composto da Salieri
su un testo di Pietro Metastasio già messo in musica da Antonio Caldara
e da Niccolò Jommelli. Proprio in relazione a queste due versioni, più
che alle
Passioni
e agli oratori del mondo protestante, andrebbe collocata
l’«azione sacra in due parti» che Salieri tratta con uno stile strumentale
e vocale tendente alla teatralità, alla rappresentazione, alla trasmissione
di sentimenti che enfatizzano la differenza tra l’umanità del Cristo da un
lato, e la divinità del mistero dall’altro.
venerdì 15 aprile
ore 21 - turno blu
sabato 16 aprile
ore 20.30 - turno rosso
Auditorium Rai
Arturo Toscanini
Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Ryan McAdams
direttore
Paolo Fanale
tenore
Vladimir Baykov
basso
Vadim Repin
violino
Prokof’ev
Ouverture su temi ebraici
op. 34b
¥ajkovskij
Concerto per violino
e orchestra op. 35
Rimskij-Korsakov
Mozart e Salieri
, opera
in un atto e due scene
giovedì 21 aprile
ore 20.30 - turno rosso
venerdì 22 aprile
ore 21 - turno blu
Auditorium Rai
Arturo Toscanini
Orchestra Sinfonica
Nazionale della Rai
Coro Filarmonico
«Ruggero Maghini»
di Torino
Ottavio Dantone
direttore
Claudio Chiavazza
maestro del coro
Roberta Invernizzi
soprano
Sara Mingardo
contralto
Jeremy Ovenden
tenore
Vito Priante
basso
Salieri
La Passione di Gesù
Cristo
, oratorio per soli,
coro e orchestra
sistemamusica
orchestrasinfonicanazionaledellarai
17