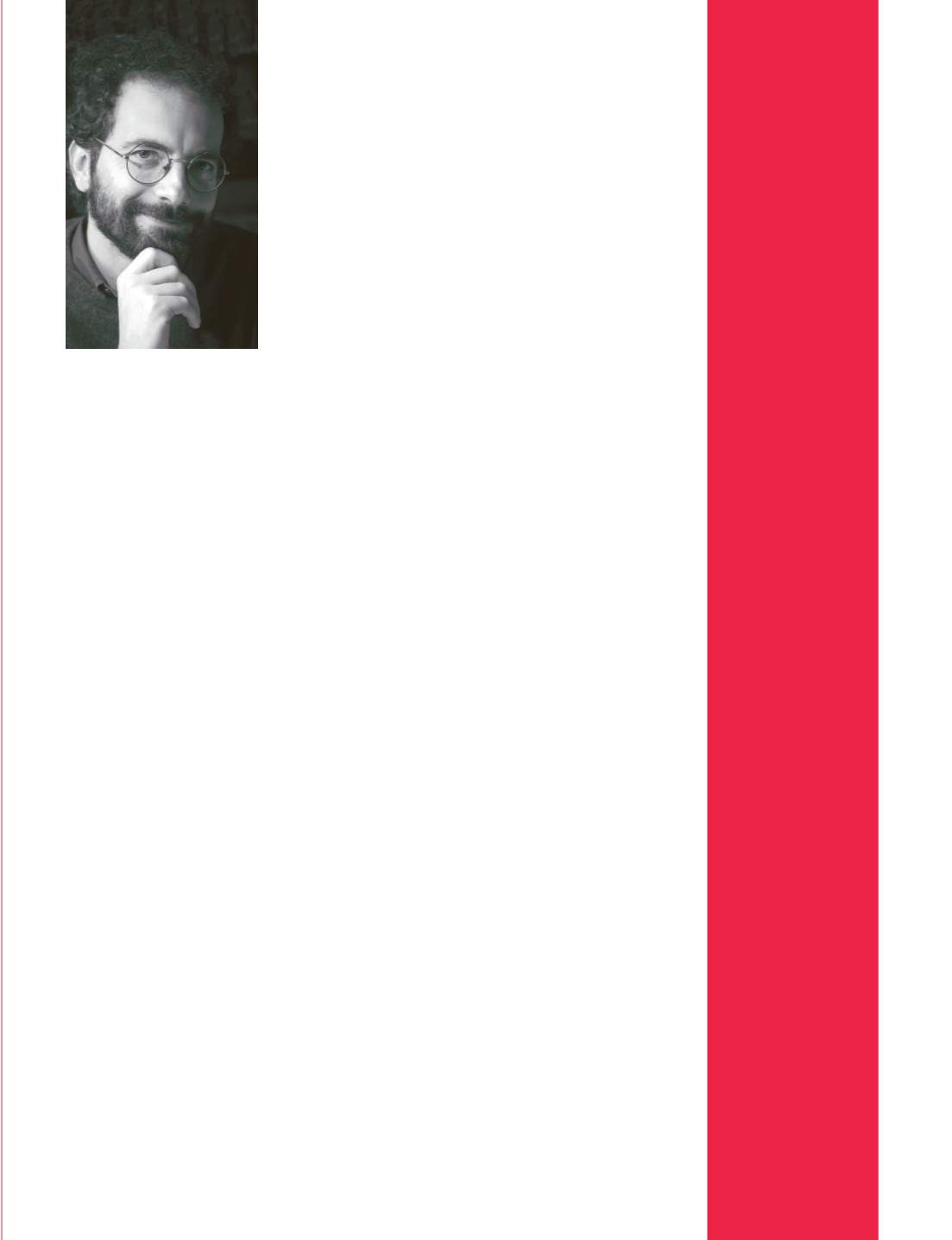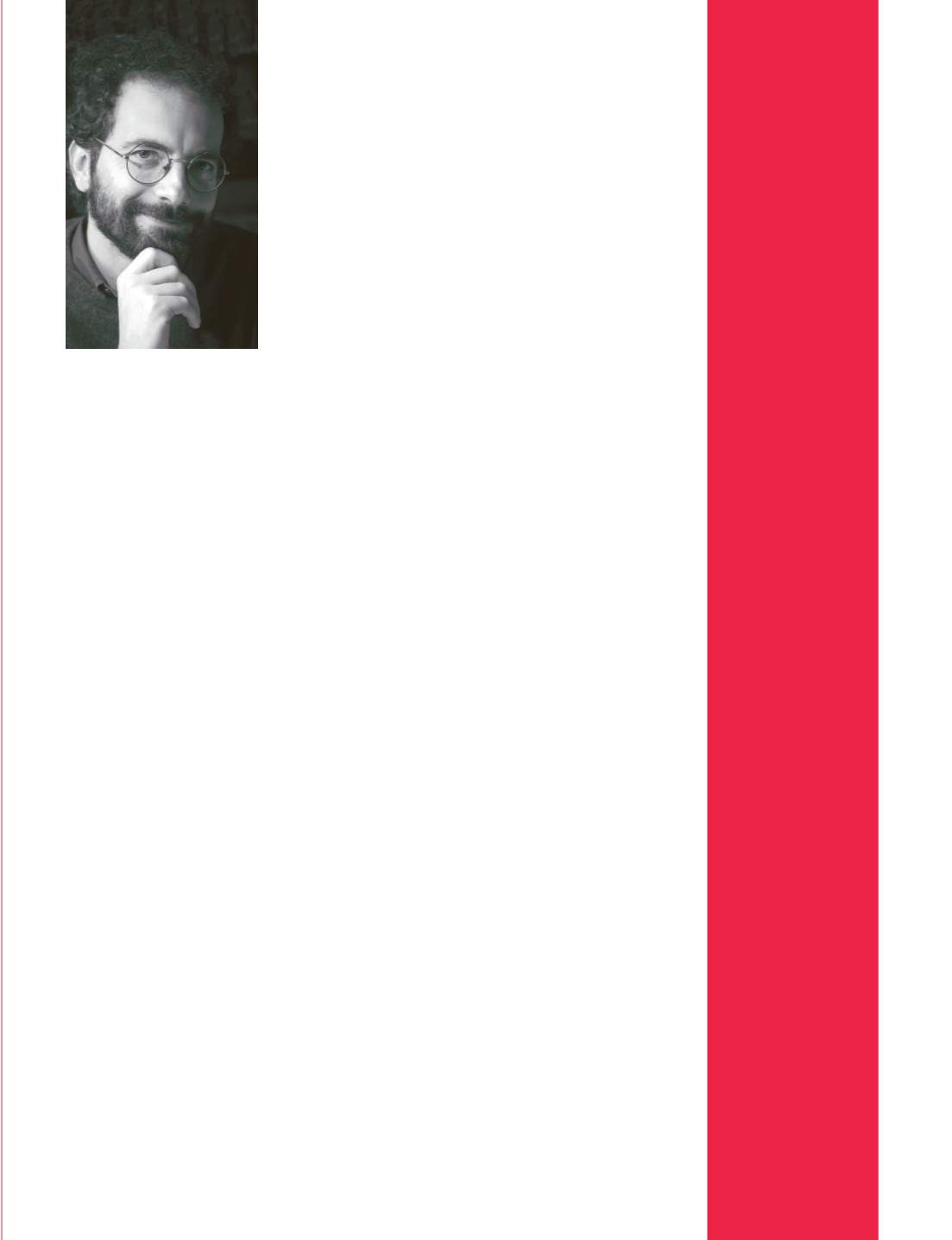
Editoriale
Nicola Campogrande
U
na sera, forse ven’anni fa, Mario Brunello si presentò
all’Auditorium della Rai e, prima di cominciare a suonare,
si mise a parlare. Spiegò il programma (curiosamente
composto da brani didattici per violoncello), le sue ragioni,
i suoi punti di forza, e mi ricordo ancora la gioia, il piacere
che provai per quella inattesa guida all’ascolto. Non
che fosse una primizia assoluta – se non altro le mitiche
lezioni-concerto televisive di Bernstein erano sullo sfondo;
ma allora non usava presentare il concerto: un musicista
entrava, cominciava a suonare e il pubblico ascoltava.
Oggi solisti, direttori, cameristi e cantanti si sentono
sempre più in dovere di parlare prima di far musica;
e gli ascoltatori, benché dotati di un programma di sala
con informazioni sui brani, sembrano sempre meno in
grado di cavarsela da soli. Si sentono spiazzati nel doversi
abbandonare all’ascolto senza una rete di protezione che
li salvi da eventuali pericoli. Hanno bisogno – dicono
i maligni – di sapere che cosa provare.
Ora, pur condividendo anch’io quelle stesse esigenze,
e con l’aggravante di dedicarmi da tempo a varie forme
di introduzione all’ascolto, sto cominciando a chiedermi
se non si stia passando il segno. Se, per facilitare
l’approccio alla musica classica, non stiamo finendo con
l’anestetizzarla. Se, per renderci un brano più familiare,
non ne distruggiamo la sorpresa, l’imprevedibilità. Se non
andiamo contro la specificità propria dell’arte dei suoni
che consiste nel parlare in modo individuale e diverso a
ciascuno di noi.
Siamo così sicuri, insomma, che la musica classica abbia
sempre bisogno di una traduzione, come si fa con le lingue
straniere (o peggio, con quelle morte)? Non è che, per
l’ansia di farci sfuggire qualcosa, alla fine ci concentriamo
sulle spiegazioni e arriviamo all’ascolto senza più tensione,
curiosità, desideri?
Parlare prima di suonare